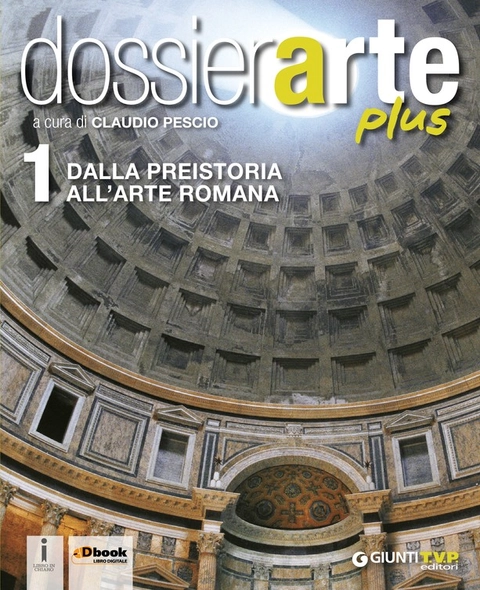Durante l’età repubblicana gli architetti e gli ingegneri romani, che in massima parte sono rimasti anonimi, si dedicano non solo a perfezionare
tecniche più antiche – ispirandosi in primo luogo ai modelli greci – ma anche a testarne di nuove.
Sono soprattutto la
sperimentazione e l’impiego di nuovi materiali, insieme alla particolare attenzione data all’utilità degli edifici, a differenziare la
storia dell’architettura romana da quella greca.
FOCUS
MATERIALI E TECNICHE ARCHITETTONICHE
Dossier Arte plus - volume 1
Dalla Preistoria all'arte romana
Laura Fenelli, Emanuela Ferretti, Laura Guasti, Claudio Pescio
Treccani Giunti TVP, 2015
VERSIONE DIGITALE
ALTRI FORMATI E SERVIZI