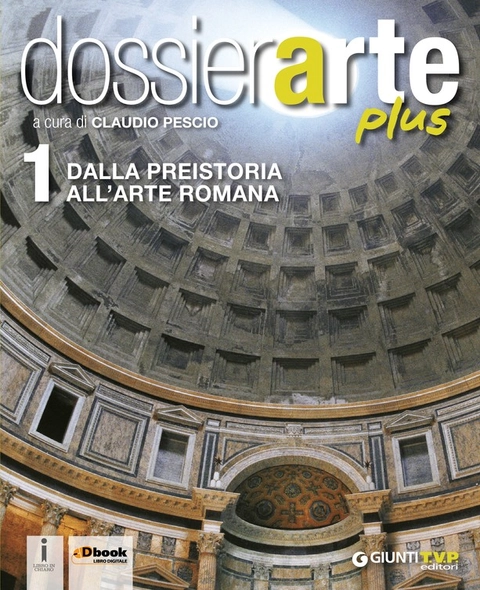10. ROMA IMPERIALE >> L’arte romana in età imperiale
I sarcofagi figurati
Dossier Arte plus - volume 1
Dalla Preistoria all'arte romana
Laura Fenelli, Emanuela Ferretti, Laura Guasti, Claudio Pescio
Treccani Giunti TVP, 2015
VERSIONE DIGITALE
ALTRI FORMATI E SERVIZI