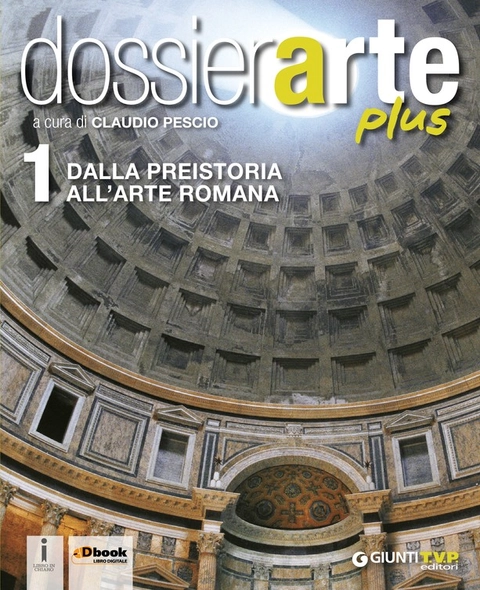Le statue potevano far parte del corredo funerario (► p. 45) o essere usate per
ornare cappelle e templi, assumendo così un valore votivo. Ouest’ultima destinazione riguardava esclusivamente le statue raffiguranti
i faraoni o i dignitari di corte, che in genere erano di notevoli dimensioni.
Il materiale maggiormente utilizzato nella statuaria era la pietra. Si conoscono esemplari in pietra tenera come il calcare e in pietra dura come il granito. In Epoca Tarda vengono preferiti lo scisto e la grovacca, che conferiscono, nella resa delle forme, una particolare morbidezza. Sono rare le statue in metallo, mentre quelle in legno, meno costose, erano più diffuse tra i privati cittadini.
Il materiale maggiormente utilizzato nella statuaria era la pietra. Si conoscono esemplari in pietra tenera come il calcare e in pietra dura come il granito. In Epoca Tarda vengono preferiti lo scisto e la grovacca, che conferiscono, nella resa delle forme, una particolare morbidezza. Sono rare le statue in metallo, mentre quelle in legno, meno costose, erano più diffuse tra i privati cittadini.