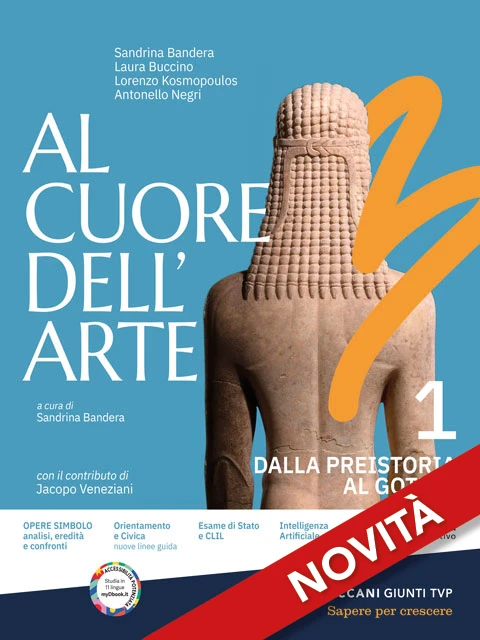AL CUORE DELL’ARTE
L’architettura ellenistica mostra le trasformazioni di un contesto sociale e politico che, superata l’idea della pólis, si avvale sia dei precedenti modelli classici sia di novità formali introdotte nelle nuove articolazioni dello spazio urbano.
Gli ordini architettonici vedono un progressivo abbandono del dorico a favore dello ionico e del capitello corinzio, esteso anche alle peristasi esterne dei templi. Numerosi architetti, che si muovono in tutto il Mediterraneo, operano al servizio dei sovrani ellenistici e promuovono i piani urbanistici delle nuove capitali, enfatizzati da sistemazioni scenografiche, come i terrazzamenti che sfruttano i pendii naturali del terreno e i lunghi porticati (stoái) che trasformano i principali spazi cittadini in complessi chiusi e organici.
Dalla Preistoria al Gotico
Sandrina Bandera, Laura Buccino, Lorenzo Kosmopoulos, Antonello Negri
Treccani Giunti TVP, 2025
VERSIONE DIGITALE
ALTRI FORMATI E SERVIZI